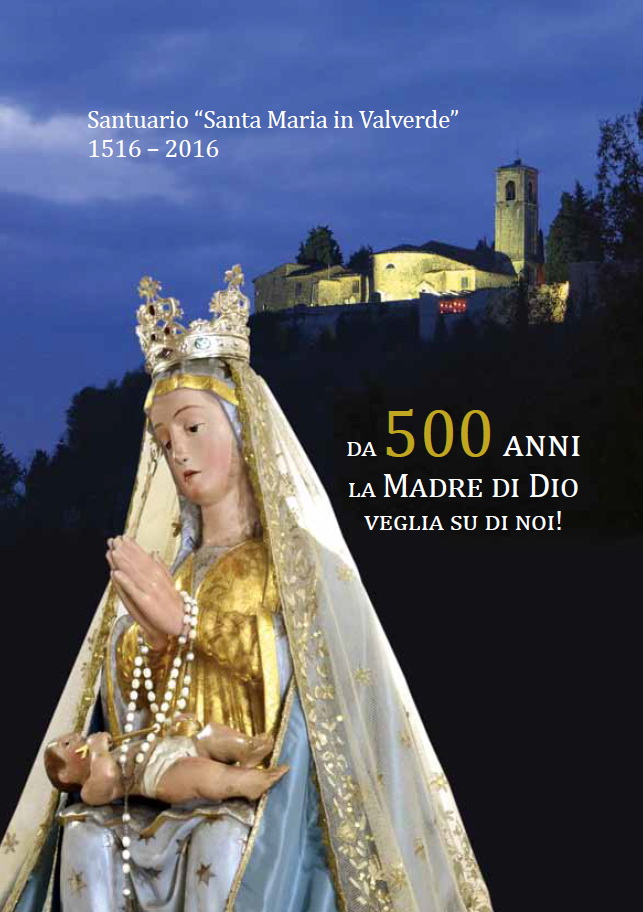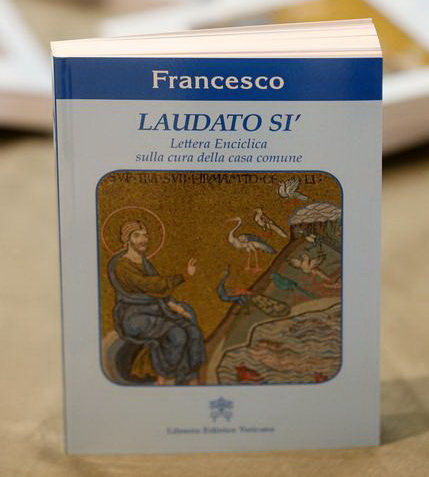Il suo profilo e le origini
Carlotta e Giovanni sono una giovane coppia di sposi. La loro casa è in quegli anni ad Arbizzano, nella corte dei Feriani. Qui sono mezzadri. Allora la Valpolicella non era quella di adesso: essere mezzadri significava una vita di sacrifici.
Poi, in quella casa, il primo maggio del 1928 nasce Luigi. È il quinto dei loro figli, che alla fine saranno otto: tre suore e un prete.
Dell’infanzia e della giovinezza di don Luigi abbiamo solo frammenti di episodi, di cui ogni tanto gli piaceva raccontare. Ma la cosa importante è che la sua famiglia resterà per lui, per sempre, un riferimento inossidabile. Poi il legame è proseguito con i tanti nipoti e pronipoti, che abbiamo anche visto qui. Tuttavia, pur contando molto sulla sua famiglia, quando avvertiva di poter diventare un peso, si toglieva di torno. La scelta di andare alla casa di riposo, ad esempio, è stata una di queste. Quante volte ha detto anche a me: “Questa è una decisione mia, l’ho voluta io”.
Adesso, per la descrizione che segue, chiedo già scusa se non tutti i passaggi saranno chiari. So che lui mi capirà e perdonate se salterò qua e là tanti dettagli (di cui sarebbe bello raccontare, ma questa non è la sede opportuna). Chiedo scusa se nel mio racconto sembrerà prevalere l’esperienza della Madonna della Fraternità, ma grazie a chi mi ha preceduto, che ha detto tutto il resto. Spero comunque di non far torto a nessuno.
Il ministero
Il 27 giugno 1954 viene ordinato prete. La sua è già una vocazione adulta. Passa i primi anni come curato di San Nazzaro.
Dopo alcuni anni come curato di San Nazzaro, viene assegnato a Pazzon, Lubiara, Caprino e infine parroco a Lubiara. Ovunque sia passato, ha coinvolto le persone e ha lasciato segni di amicizia e fraternità. Ha contagiato di affetto, creato legami e seminato germi di comunità. Questo è stato il tratto distintivo che lo ha sempre accompagnato e con cui tutti lo abbiamo conosciuto.
Quando era ancora parroco a Lubiana, tra il polo ferroviario di Porta Nuova e le fabbriche della ZAI di Verona, partecipava alla pastorale del mondo del lavoro, che allora era sinonimo di mondo operaio.
Nel 1972, ancora parroco a Lubiana, su richiesta del vescovo Giuseppe Carraro, gli viene chiesto di dedicare attenzione alla nuova realtà abitativa delle case Gescal a sud delle Golosine, perché lì nasceranno molte altre abitazioni. Per quasi un anno farà la spola con Lubiara.
Dal 1972, in via Patiglione 13, con il permesso delle case Gescal, ricava sotto i portici dei condomini un luogo che funge da chiesetta, ufficio e anche camera, dove qualche volta passa la notte per risparmiare il viaggio. È l’inizio di una nuova esperienza.
L’8 ottobre 1973 lascia definitivamente Lubiara, perché il vescovo lo nomina vicario della vicaria indipendente Madonna della Fraternità, che diventa parrocchia poco dopo, a Natale dello stesso anno.
Agli incontri dichiara sempre l’intento che anima il suo ministero:
“Il vescovo mi ha mandato qui non tanto per costruire una chiesa di mattoni, ma una comunità di persone. Una chiesa di pietre vive.”
L’Istituto Don Calabria, che allora era in via Roveggia, apre le porte per le celebrazioni. Per raccogliere la gente e creare punti di incontro, nasce la prima casa-famiglia in via Roveggia, una delle prime abitazioni provvisorie, un punto di aggregazione per decine di giovani e famiglie.
Recupera poi la chiesetta di via Chioda, pianta una tenda in via Roveggia e un’altra in Zai. Alcune strutture vengono sostituite con prefabbricati smontati in Friuli. Arriva anche un vagone ferroviario, fino al prefabbricato di via Ombrone, che diventerà la chiesa parrocchiale definitiva.
Anch’io, personalmente, lavorando in quel tempo proprio lì vicino, in una grossa fabbrica, ho cominciato con altri amici a frequentare quell’ambiente. Posso dire che per la mia vocazione il Signore si è servito della sua complicità. Una volta diventato prete, mi sono ritrovato a condividere con lui, alla pari, lo stesso ministero per sette anni.
Un’impresa la comunità. Per don Luigi, con la sua ironia, potremmo usare la parola che ama Papa Francesco: un’”ecclesiologia dello scarto”, una piccola chiesa fatta di porte aperti per tutti, credenti e atei.
Se lui trovava porte aperte, non lo faceva solo per l’inclusione, ma mai per l’esclusione. Non c’erano scarti, come dice Papa Francesco. Raccoglieva tutti e tutto, creando una comunità in cui nessuno era primo o ultimo.
Tutto ciò che si poteva ritenere scarto diventava roba buona. E non solo per le persone, ma anche per gli oggetti. Spesso raccoglieva macchine, minibus, roulotte, tutto ciò che gli veniva regalato. Il valore non stava nelle cose, ma nelle persone che, di volta in volta, riusciva a conquistare.
Così faceva anche con le persone: non c’erano scarti. Lo dimostrano il campo nomadi di Forte Azzano, le collaborazioni con don Francesco Cipriani, la scuola circense di via Germania e le tante situazioni di disagio sociale ed economico nel quartiere.
Per lui la parola “comunità” significava che anche noi preti dovevamo esserlo. Ad esempio, la parrocchia lasciava anche il piccolo contributo economico che spettava alla cassa, così come l’offerta personale per la messa celebrata. La parrocchia era una famiglia in cui si condivideva tutto: la cena in giorni fissi, le attività estive alla Fraternità, il sostegno delle suore infermiere, il volontariato in mille forme.
Le attività erano così numerose che raccontarle adesso sembrano roba da fantascienza. Spesso al limite dell’azzardo, ne faceva una e già ne proponeva altre dieci. Confesso che era difficile stargli dietro.
Quanti aneddoti potremmo raccogliere tra i presenti qui e anche tra i non presenti?
E i giovani? Per loro tutto. Da un Jukebox nella prima casa di via Roveggia, al campo sportivo, dove prima c’era un immondezzaio pubblico. Una scelta che gli costò una denuncia e un processo. Il motivo? Non essersi allineato o schierato politicamente in un periodo particolarmente caldo. Ad ogni modo, ne uscì prosciolto perché il reato non sussisteva.
E poi i mitici campeggi, i primi dei quali facevano invidia a quelli di oggi. Una vera scuola di sopravvivenza, altro che avventura in stile Pechino Express!
La Provvidenza, evidentemente, non gli faceva mai mancare nulla. Ci furono gli anni dei custodi, quelli della scuola serale per chi non aveva potuto prendere la terza media, i gruppi di adolescenti, i giovani, gli scout. E poi c’era lui, con la sua patente di guida pubblica, anche autista del pulmino per portare i bambini a scuola, prima tra Spiazzi e Caprino e, se non mi sbaglio, anche qui tra Marano e San Rocco.
Tutto da prete, un prete che parlava e viveva per amore. Un prete che rifletteva Cristo nella sua Chiesa. Tutto per rendere bella e desiderabile la fede cristiana.
Un prete fino alla fine
Concludo il ritratto della sua personalità con una testimonianza recente, che racconta gli ultimi anni della sua vita, fino all’esperienza della casa di riposo.
Mi è stato confidato:
“Semplice di cuore, generoso senza misura, attivo, lavoratore instancabile, introspettivo e sempre prete, sempre pastore. Visitava le persone, partecipava alle cene, si prendeva cura di tutto e di tutti. in casa di riposo, non era un ospite come gli altri: fino all’ultimo ha continuato ad accompagnare gli altri ospiti più come guida spirituale che come ospite a sua volta.”
Era prete sino alla fine. Anche la casa di riposo per lui era un luogo di missione e preghiera.
Un dono raro e prezioso, e qualche volta persino pesante da portare, era la sua capacità di cogliere al volo se non addirittura prevenire le intenzioni di chiunque gli si avvicinasse, dai superiori all’ultimo che lo incontrava. Con i superiori ascoltava e obbediva, poi magari raccontava con entusiasmo anche le gioie più piccole. Talvolta trovava il coraggio di esternare, con discrezione, l’amarezza per certi trattamenti poco delicati ricevuti. Lo faceva con pochi, in privato. L’ha fatto anche con me, raccomandandomi però di non parlarne.
In ogni caso, finiva sempre per dire:
“Ma, ad ogni modo, io gli ho voluto bene.”
Oppure, come diceva lui:
“Ma mi ghe voi ben!”
Non so quante volte l’avrete sentito dire questa frase. Era la sottile ironia con cui amava non prendersi troppo sul serio.
Io, però, gli ho voluto bene.
Questa è una frase che, in questi giorni, mi hanno ripetuto in tanti, mentre cercavo di scrivere questo profilo. Tutti hanno voluto riassumere il proprio rapporto con lui dicendo:
“Mi ha voluto bene.”
Grazie, Signore, per il dono di don Luigi. È stato il tuo biglietto da visita con cui ti sei presentato nelle nostre vite.
E ancora grazie per l’amicizia e la gioia che ha seminato. A presto tanto perché un giorno è come mille anni e mille anni è come un giorno solo.