Dalla riflessione di don Augusto Barbi, a s. Maria in Valverde, lunedi 29 febbraio
MARIA NEI VANGELI DELL’NFANZIA
(Lc 1-2)
- E’ interessante la prima presentazione che ne abbiamo da parte del narratore (Lc 1,26-27): prima ancora del nome – che sarà dato solo alla fine – veniamo a conoscere che essa risiede nello sconosciuto villaggio di Nazaret; che è una ragazza giovane (parthenos), la quale in seguito si qualificherà, nella sua obiezione (Lc 1,34), come “vergine”, dal momento che “non ha conosciuto uomo”; che è stata (ed è) promessa sposa ad un discendente di Davide, di nome Giuseppe.
Più avanti, per il fatto che al momento della purificazione offrirà (Lc 2,24) una coppia di tortore o di giovani colombi anziché un agnello (cfr Lv 12,8), verremo a sapere indirettamente che è di origine umile e di condizione povera. Lei stessa lo confermerà nel magnificat quando affermerà che “Dio ha guardato alla condizione umile della sua serva” (tapeinosis: cfr.Lc 1,48).
Due interrogativi emergono da questo quadro sintetico e saranno da tenere presenti successivamente:
– La condizione umile e povera di Maria, che sorte incontrerà?
– La tensione tra verginità/sponsalità, che soluzione troverà in seguito?
- Se questa è la presentazione del narratore, interessante è rilevare per contrasto lo sguardo che Dio getta su Maria e che è rivelato dalle parole della figura angelica.
Nell’annunciazione l’angelo saluterà Maria, invitandola a “gioire” (Lc 1,28) perché essa sarà resa partecipe della mistero della salvezza. La gioia, infatti, nell’opera di Luca, non è solo uno stato psicologico, ma connota coloro che hanno fatto esperienza della salvezza divina.
Inoltre l’angelo la qualifica come “destinataria del favore e della grazia” (Lc 1,28) divina. Più avanti le dirà che “ha trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30) e ancora la rassicurerà che “il Signore è con lei” per sostenerla nel compimento di una straordinaria missione (Lc 1,28).
Interessante è il confronto con Zaccaria. Mentre a Zaccaria, di cui era stata lodata la “giustizia” – la rettitudine religiosa e morale (Lc 1,6) -, l’angelo annuncia che “è stata esaudita la sua supplica” (Lc 1,13) e che sua moglie anziana e sterile avrà un figlio, a riguardo di Maria non viene esaltata nessuna qualità morale, ma semplicemente è messo in risalto il favore e la benevolenza gratuita di Dio verso una ragazza di condizione umile. Maria potrà nel suo inno, con verità, magnificare soltanto l’iniziativa gratuita di Dio: “grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e santo è il suo nome” (Lc 1,49).
Nella realtà di Maria, emerge dunque, innanzi tutto, il mistero dell’insondabile gratuità divina e della misericordia di un Dio che liberamente rivolge il suo favore verso chi è povero ed umiliato.
Questa gratuita divina, che si manifesta in modo unico e singolare in Maria – modello dei credenti – fa pensare come anche la nostra esistenza cristiana sia posta sotto la grazia incondizionata di Dio.
- A che cosa è finalizzata questa benevolenza gratuita che Dio riserva all’umile Maria?
- a) La finalità è quella di renderla, per un privilegio singolare, la madre del suo Figlio. Glielo annuncia l’angelo dicendole: “concepirai un figlio – e stranamente a differenza di Zaccaria che imporrà lui il nome a suo figlio – e tu lo chiamerai Gesù”. Questo figlio sarà il Figlio dell’Altissimo e sarà il Messia discendente di Davide”. Elisabetta stessa la riconoscerà come “madre del suo Signore” (Lc 1,43). Gli angeli lo annunceranno come il “Salvatore, Cristo e Signore, nato nella città di Davide” (Lc 2,11)
A questo annuncio angelico, Maria reagisce con un’osservazione di natura biologica “come potrà accadere questo” (Lc 1,34), dal momento che il suo proposito di verginità – per cui “non conosce uomo” – rende l’annuncio umanamente impossibile.
La risposta dell’angelo è stranamente, invece, di natura teologica. egli riconduce, infatti, questa nascita allo Spirito creatore e vivificante di Dio, così che il figlio, che da lei verrà generato, sarà davvero il Figlio dell’Altissimo (Lc 1,32). Ella diventerà, dunque, la madre del Figlio di Dio: la vergine/sposa delineata all’inizio diventa madre per la grazia e la potenza vivificante di Dio. Ella è la vergine/madre del Messia davidico di cui parla Is 7,14: “La vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emmanuele”.
Il segno che le è dato – la maternità di Elisabetta – rimanda alla potenza di Dio “a cui nulla è impossibile” (cfr. Lc 1,36-37), perché è capace di fare dono della maternità alle donne sterili ed è dunque in grado di rendere madre una vergine.
- b) Maria vivrà questa maternità in una singolare tensione: quello che genererà è il suo figlio, ma è anche il figlio di Dio.
Ella dunque lo curerà con la tenerezza e la passione di una madre, come ripetutamente sottolineerà il racconto della nascita: “lo dà alla luce, lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia” (Giuseppe è sempre escluso) (cfr. Lc 2,7.12.16); gli imporrà il nome, come indicato dall’angelo (Lc 2,21); si preoccuperà, come ogni madre israelita, di portare questo suo primogenito al tempio per offrirlo al Signore (Lc 2,22-23); sarà angosciata e interverrà con un materno rimprovero, come ogni madre, quando non lo ritroverà, dopo accurate ricerche, nella prima partecipazione alla festa di pasqua a Gerusalemme: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo” (Lc 2,48). C’è una maternità tanto umana in questi brevi cenni che i racconti dell’infanzia ci offrono. E Gesù accetterà questo ruolo materno di Maria, quando, tornato a Nazaret, sarà “loro costantemente sottomesso” (Lc 2,51).
Nel contempo Maria avvertirà che questo suo figlio le sfugge. Lo sentirà nel momento in cui Gesù, al tempio, le rivolgerà la misteriosa parola: “non sapete che io devo essere nelle cose del Padre mio” (Lc 2,49). Ella comprenderà, dalla parola che Simeone rivolge soltanto a lei, che questo Figlio ha una missione singolare: Egli sarà segno di fronte al quale si creerà una spaccatura in Israele (“rovina e resurrezione di molti”: cfr. Lc 2,34-35)), così che egli farà venire alla luce i pensieri nascosti che stanno nei cuori. Questa spaccatura porterà il suo figlio verso il destino di un Messia rifiutato, sofferente ed ucciso con violenza. Questa sofferenza si rifletterà anche su sua madre – “e tu, per quanto ti riguarda, una spada attraverserà la tua anima” (Lc 2,35) – ed ella sarà chiamata a partecipare, lungo tutto il suo sviluppo, a questo percorso di incomprensione e di rifiuto che il Figlio, fedele alla sua missione, dovrà affrontare.
- Questa maternità singolare, pur essendo anzitutto frutto della incondizionata grazia divina, non si realizza senza la docile risposta di Maria. Con questa risposta di fede, Maria diventa modello della fede per ogni discepolo (anche per noi dunque). Ma come si caratterizza questa fede di Maria?
- a) La sua risposta all’annuncio dell’angelo (Lc 1,38) rivela Maria che accetta umilmente, come “serva”, che si realizzi nella sua vita quell’impensato disegno di Dio (rema: significa parola/fatto) che le è stato annunciato. Ella si dispone dunque a che Dio intervenga, per mezzo suo, nella storia umana con il suo piano di salvezza. Rinuncia ai suoi propositi, alle sue proiezioni di sé, per affidarsi totalmente all’iniziativa di quel Dio a cui nulla è impossibile. Maria crede che, nell’acconsentimento della libertà umana che si dispone fiduciosamente, Dio possa operare nella storia ciò che resta umanamente imprevedibile e impensabile. Per questo Elisabetta la proclamerà: “Beata tu che hai creduto che c’è un compimento alle cose dette a te da Dio” (1,45).
- b) Questa fede radicale di Maria è però una fede in progressione.
– Il racconto dell’annunciazione rende evidente questa progressione. Al saluto dell’angelo che la qualificava “destinataria della grazia divina”, Maria risponde dapprima con un atteggiamento di spaesamento (fu turbata) e con una riflessione/discernimento interiore che mette in atto la ragione: “dibatteva dentro di sé che significato avesse questo saluto” (Lc 1,29). Poi mette davanti la difficoltà e l’obiezione della propria verginità (Lc 1,34) e solo alla fine si arrende alla fede obbediente (Lc 1,38). E’ questo, di Maria, un caso unico nella rivelazione biblica, nel quale colui che riceve un annuncio divino vi accede e vi aderisce solo progressivamente.
– Nel racconto della nascita, quando i pastori riferiscono l’annuncio angelico, “Maria conservava insieme tutte queste cose confrontandole dentro il suo cuore” (Lc 2,19). La fede di Maria è una fede che mantiene con cura la memoria degli eventi e li mette a confronto per comprendere progressivamente quel disegno divino che va dipanandosi nella storia in maniera inattesa. Essa deve tenere a confronto l’annuncio grandioso della nascita del Figlio di Dio con la realtà sconvolgente di quel bambino nato nella povertà e nel disagio. Così probabilmente avverrà anche in seguito, quando la sua radicale fede iniziale dovrà confrontarsi con la storia inattesa di questo Figlio, incompreso, criticato e rifiutato, e la sua fede dovrà accoglierLo in forma sempre nuova. Il suo “si” pieno dell’inizio avrà bisogno di tanti altri “sì” di conferma mano a mano che si manifesterà la storia di un Gesù, “segno contraddetto”.
– La conferma avviene nell’episodio del tempio. Di fronte allo smarrimento del Figlio, c’è la naturale angoscia, tutta umana, di Maria. Ad essa Gesù risponde che “deve essere nelle cose del Padre” (Lc 2,49), ottenendo da parte di Maria “la non comprensione”: “essi non compresero le sue parole” (Lc 2,50). Alla fine Gesù si sottomette ai genitori a Nazaret”. L’annotazione finale che “sua madre conservava questi fatti/parole nel suo cuore” mostra nuovamente la fede pensosa di Maria, chiamata a dire la sua adesione ad un agire di Dio che nella storia del suo Figlio si manifesta in forma apparentemente contraddittoria e certamente inattesa.
- c) La fede di Maria si traduce in preghiera di lode
L’inno del Magnificat , intessuto di riferimenti veterotestamentari, riflette l’esperienza di Maria. Ella fa diventare questa esperienza motivo di lode e di riconoscenza gioiosa. L’inno, infatti, prende avvio da ciò che Maria ha intravisto nella sua esperienza di serva, di ragazza di condizione umile a cui Dio ha riservato grandi cose, rendendola madre del suo Figlio (Lc 1,47-49). A partire dal vissuto di Maria, l’inno allarga lo sguardo all’agire di Dio che si manifesterà nella storia di Gesù (Lc 1,50-53): è un agire che sconvolge i ruoli e rovescia le condizioni sociali. Esso rivela la misericordia di Dio che innalza gli umili e concede i beni agli affamati (cfr: le beatitudini in Lc 6,20-21) e che, mettendo la sua potenza a servizio della misericordia, depone i potenti dai troni e rimanda i ricchi a mani vuote (cfr. la maledizioni in Lc 6,24-25), sconfigge in tal modo coloro che umiliano e opprimono i poveri. L’inno chiude (Lc 1,54-55) celebrando la fedeltà di Dio nella storia della salvezza. Questo Dio, infatti, che aveva donato in Abramo la sua promessa e la sua alleanza ad Israele, ora concede, per la sua misericordia, il compimento di queste realtà nell’evento salvifico di Gesù. Su questo Dio fedele alle sue promesse si potrà sempre fare affidamento anche nel futuro.
E’ significativo che Maria, presentata nel Magnificat come modello della fede orante, sia di nuovo menzionata all’inizio degli Atti degli Apostoli (1,14) come parte di quel primo nucleo di comunità cristiana che, in una preghiera perseverante, chiede ed attende il dono pentecostale dello Spirito che farà nascere la chiesa come popolo profetico e missionario. Di nuovo, Maria appare come modello di quei credenti a cui “il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo” perché glielo chiedono insistentemente (cfr. Lc 1,13).
- d) La fede di Maria è una fede obbediente
Maria dà compimento nella propria vita alla parola che gli è stata annunciata. Non solo risponde positivamente all’angelo (“avvenga in me”: Lc 1,38), ma subito dopo si affretta (1,39s.) ad andare e a portare aiuto alla cugina Elisabetta, di cui l’angelo le ha anticipato la straordinaria maternità. In seguito, ella sarà mostrata a più riprese obbediente alla “legge del Signore” e, dunque, alla sua parola (cfr. Lc 2,23.24.39).
Al riguardo sono significativi i passi nel quali Luca parla ancora della madre di Gesù. In essi è chiaramente delineata la prospettiva che la vera “maternità” feconda, non è semplicemente quella che si attua nella generazione e nell’umana cura materna, ma è quella che si realizza nell’ascolto operoso della Parola di Dio.
– In una piccola sezione dedicata all’ascolto della Parola (cfr. 8,11-21), Luca aveva mostrato, in un primo momento, “come” occorre ascoltare la parola di Dio: essa deve essere accolta in un cuore libero dalle ansie, dalle ricchezze e dalla brama del piacere; in un cuore “bello e buono”, perché bene orientato verso Dio, per arrivare poi a portare frutti in un cambiamento di vita, che si realizza giorno per giorno “con perseveranza” anche in mezzo alle difficoltà e alla prove che la vita riserva (cfr. Lc 8,11-15). Utilizzando poi l’immagine della lampada che illumina tutti quelli che entrano in una casa, Luca aveva lasciato capire che la Parola accolta e vissuta diventa inevitabilmente testimonianza mediante la quale la luce di Cristo è offerta al mondo (cfr. Lc 8,16-18). A conclusione (cfr. Lc 8,19-21) presenta una piccola scena in cui la “madre” e i fratelli si fanno presenti a Gesù e desiderano “vederlo”: vogliono, cioè, fargli visita e incontrarlo per affermare il loro legame di sangue. A fronte di questo di questo desiderio umano, Gesù pronuncia una solenne sentenza: “mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la fanno” nella loro vita. E’ abbastanza chiaro che con questa sentenza Gesù delinea una nuova qualità di “maternità”, di cui Maria è modello per tutti i “fratelli” credenti. Ella, infatti, non è madre semplicemente perché ha generato e si è preso umanamente cura di Gesù, ma soprattutto perché avendo avendo accolto in Lui la parola di Dio e avendola vissuta nella propria vita, Ella è in grado di offrirlo nuovamente al mondo mediante la luce della sua testimonianza.
– In Lc 11,27-28 abbiamo un’altra piccola scena in cui è rivisitato il motivo della “maternità”. Una donna della folla, entusiasta di Gesù, pronuncia una “beatitudine” nei confronti di colei che lo ha generato: “Beato il ventre che ti ha portato e i seni che ti hanno allattato”. La benedizione è chiaramente rivolta a Maria, come colei che ha generato la vita e si è presa maternamente cura del suo figlio. Gesù corregge la beatitudine della donna: “Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la custodiscono” nella loro vita. Di nuovo la “maternità” feconda, che merita la benedizione, è quella di coloro che, accogliendo la parola di Dio nella loro vita, diventano fecondi attraverso la testimonianza a Cristo che essi rendono agli uomini. Di questa “maternità” nuova, Maria diventa figura esemplare per tutti i credenti: Elisabetta, infatti, l’aveva qualificata come “beata”, perché essa aveva creduto che nella sua vita si sarebbero compiute le parole annunciatele da Dio.
Così, per i credenti chiamati ad esercitare una nuova “maternità”, mediante la testimonianza di una Parola vissuta capace di generare altri alla fede, Maria si propone come modello incoraggiante e paradigmatico.





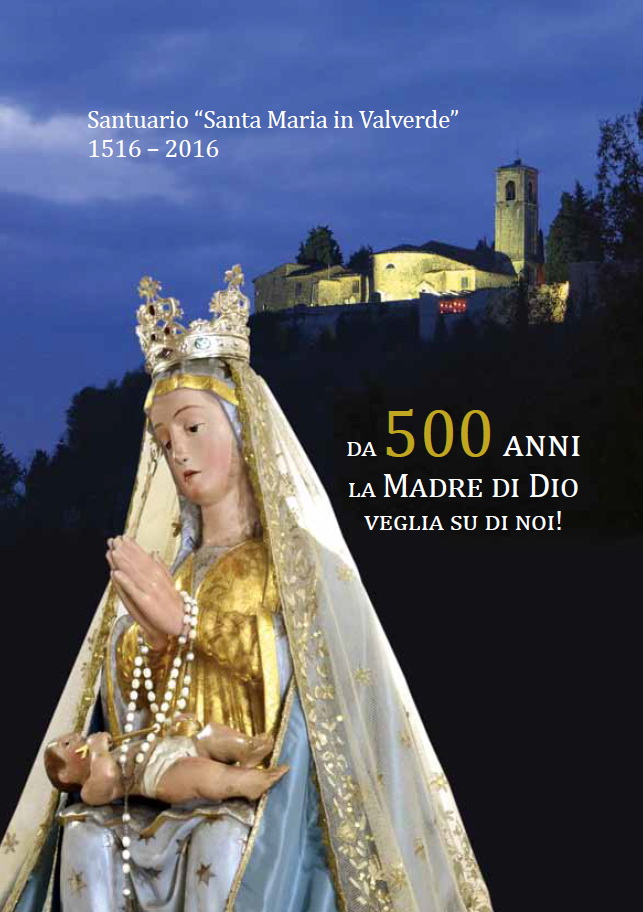
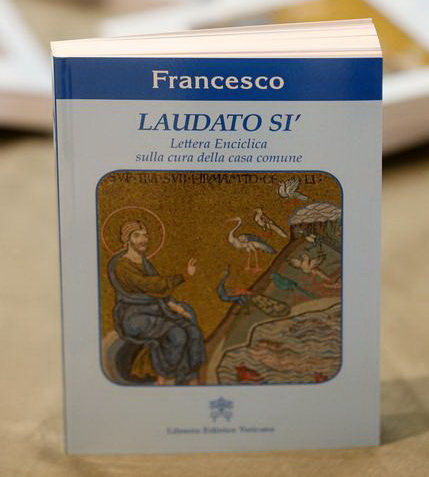
1 commento
Salve io non riesco a trovare una fonte reale e priva di interpretazioni sul fatto che dobbiamo lodare Maria,
Possiamo pero’ trovare svariati casi sullo spirito santo e sul padre senza dubbi di interpretazione, ma sulla Madonna dove ho un grande rispetto perche’ e’ la mamma di Gesu,´non riesco a trovare nessun versetto bibblico che dica di lodarla.
Grazie per il confronto.
Un saluto