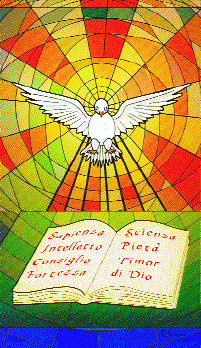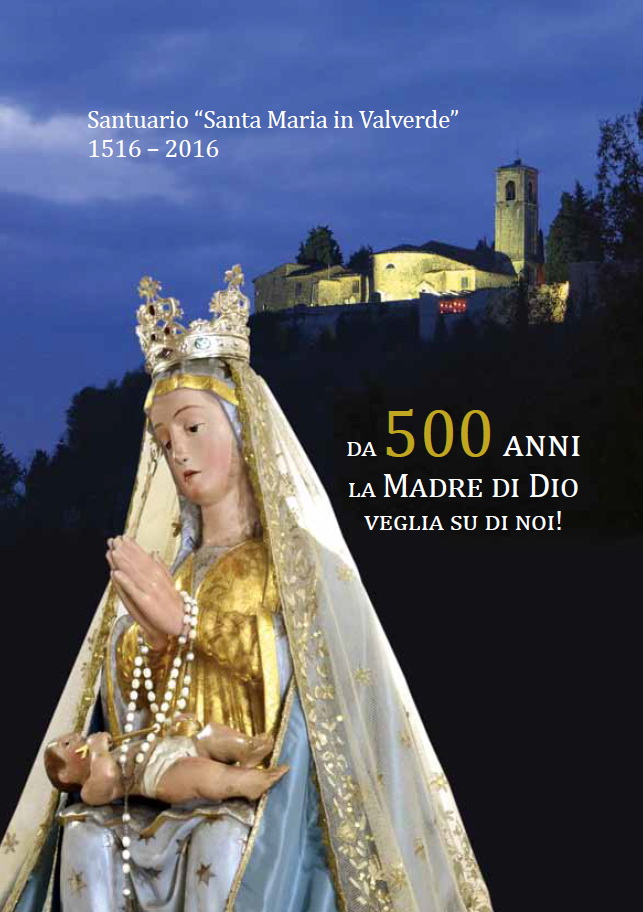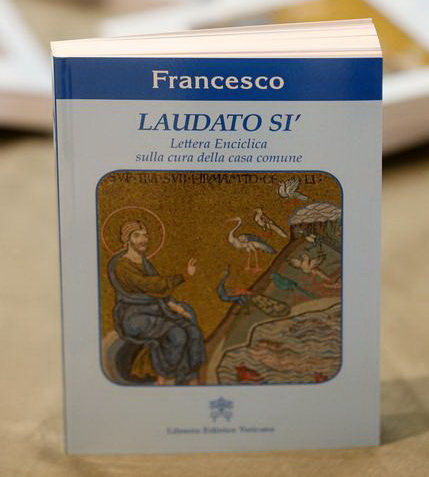Isaia 11
1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2 Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Isaia 61
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di misericordia del Signore,
Ezechièle. 36,24-28
Così dice il Signore: «Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri ìdoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio».
Gioele 3,1-3
Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave,
in quel giorni, effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra.
Atti 1,5-8
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre «quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni». Così venuti si a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudèa e la Samarìa e fino agli estremi confini della terra».
Atti 2,1-5
Al compiersi dei giorni della Pentecoste, gli Apostoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.
Dagli Atti degli Apostoli. 19, 1-6
In quei giorni, Paolo giunse a Èfeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo ». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo.
1 Corinzi 12, 4-13
Fratelli, vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudèi ò Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito.
Vangelo di Giovanni 15,26-27
Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio».
TERTULLIANO, De resurrectione mortuorum,
Viene lavata la carne, perché l’anima sia liberata da ogni macchia; viene unta la carne perché l’anima sia consacrata; viene segnata la carne, perché anche l’anima sia rinvigorita; la carne è adombrata dall’imposizione delle mani, perché anche l’anima sia illuminata dallo Spirito; la carne si pasce del corpo e del sangue di Cristo, perché anche l’anima si nutra abbondantemente di Dio.
- AMBROGIO, Trattato “Sui misteri”
Uscito dal fonte battesimale tu sei salito dal sacerdote. Pensa a ciò che è avvenuto dopo. Non forse ciò che dice Davide: «E’ come olio profumato sul capo, che scende sulla barba di Aronne»? (Sal 132, 2). E’ l’unguento del quale Salomone dice così: «Profumo olezzante è il tuo nome, per questo le giovinette ti amano» (Ct 1, 3) e ti hanno attratto a sé. Quante anime rinnovate oggi ti hanno amato, o Signore Gesù, e hanno detto: Attiraci dietro a te, noi correremo dietro la fragranza delle tue vesti (cfr. Ct 1, 4). Esse volevano sentire la fragranza della risurrezione del Signore. Cerca di capire me questo avvenga «Poiché il saggio ha gli occhi in fronte» (Qo 2, 14). Per questo scende sulla barba di Aronne, perché tu diventi «stirpe eletta», sacerdotale, preziosa (1 Pt 2, 9). Noi tutti, infatti, siamo unti con la grazia spirituale per formare il regno di Dio e il suo sacerdozio. In seguito hai ricevuto le vesti bianche come segno che ti sei spogliato dell’involucro dei peccati e ti sei rivestito delle caste vesti dell’innocenza delle quali il Profeta dice: «Purificami con issopo e sarò modo; lavami e sarò più bianco della neve» (Sal 50, 9). Infatti chi è battezzato, appare purificato, sia secondo la legge, sia secondo il vangelo. E nella figura della colomba lo Spirito Santo è disceso dal cielo.
Ricordati così che hai ricevuto il sigillo spirituale «spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di pietà, spirito di timore del Signore» (Is 11, 2), e conserva quello che hai ricevuto. Dio Padre ti ha marcato di un segno, Cristo Signore ti ha confermato e, come hai appreso dalla lettura dell’Apostolo, ha impresso nel tuo cuore, come sigillo lo Spirito (cfr. 2 Cor 1, 22).
PAOLO VI, Divinae consortium naturae
La partecipazione alla natura divina, che gli uomini ricevono in dono mediante la grazia di Cristo, rivela una certa analogia con l’origine, lo sviluppo e l’accrescimento della vita naturale. Difatti i fedeli, rinati nel santo Battesimo, sono corroborati dal Sacramento della Confermazione e, quindi, sono nutriti con il cibo della vita eterna nell’Eucaristia, sicché, per effetto di questi Sacramenti dell’iniziazione cristiana, sοnο in grado di gustare sempre più e sempre meglio i tesori della vita divina e progredire fino al raggiungimento della perfezione della carità. IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE SI CONFERISCE MEDIANTE L’UNZIONE DEL CRISMA SULLA FRONTE, CHE SI FA CON L’IMPOSIZIONE DELLA MANO E MEDIANTE LA PAROLE «RICEVI IL SIGILLO DEL DONO DELLO SPIRITO SANTO». Tuttavia, l’imposizione delle mani sopra gli eletti, che si compie con l’orazione prescritta prima della crismazione, anche se non appartiene all’essenza del rito sacramentale, è da tenersi in grande considerazione, in quanto serve a integrare maggiormente il rito stesso e a favorire una migliore comprensione del Sacramento. È chiaro che questa imposizione delle mani, che precede la crismazione, differisce dall’imposizione della mano, con cui si compie funzione crismale sulla fronte.
Rito della Confermazione
Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Accipe signaculum doni Sancti Spiritus.
IMPOSIZIONE DELLE MANI
Vescovo: Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli: Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il Battesimo, e li ha chiamati a far parte della sua famiglia,
effonda ora lo Spirito Santo, che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, e con l’unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio.
Vescovo: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito: spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello spirito del tuo santo timore. Per Cristo nostro Signore.
CRISMAZIONE
Vescovo: N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
Cresimato: Amen.
Vescovo: La pace sia con te.
Cresimato: E con il tuo spirito
ALCUNE LINEE DI SINTESI
«Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste?». Questa domanda del vescovo fa parte della professione battesimale di fede, che i bambini, i giovani e gli adulti emettono immediatamente prima della confermazione. Essi ripetono quanto i padrini al loro posto o essi stessi hanno professato con fede il giorno del battesimo: lo Spirito Santo è Dio col Padre e col Figlio e dà la vita. Nella confermazione egli sigillerà semplicemente quanto ha già operato nel battesimo. «Ricevi il sigillo – e così dicendo il vescovo traccia col crisma un segno di croce sulla fronte del confermando – dello Spirito Santo che ti è dato in dono». I Padri della Chiesa spiegarono bene il significato dell’unzione col crisma. Essi si servirono di un paragone: l’ulivo col suo tronco, i suoi rami e le sue foglie è l’immagine di Dio Padre. Il frutto dell’ulivo è l’immagine di Gesù Cristo; l’olio ricavato dalla spremitura del frutto – per così dire la parte costitutiva più raffinata dell’ulivo – è un’immagine dello Spirito Santo. Ciò significa: come l’olio e il frutto e il tronco di un albero sono un tutt’uno, così Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo! Come l’olio deriva dai fiori e dai frutti, e come i frutti derivano dal tronco e dai rami, così lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, affinché sia sempre con voi… Quando verrà il Paraclito – leggiamo un poco più avanti nel vangelo di Giovanni – che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi darà testimonianza» (Gv 14,16; 15,26). L’olio dell’unzione, nel linguaggio dei Padri della Chiesa e anche nel linguaggio dei nostri giorni, è un segno dello Spirito Santo e contemporaneamente un simbolo dell’efficacia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ma l’olio dell’unzione usato nella confermazione contiene ancora un’aggiunta preziosa: il balsamo. Tale olio, detto crisma nel linguaggio tecnico, emana un profumo gradevole. Pure questo particolare è importante per il simbolismo. Il crisma penetrante a fondo nei pori indica che lo Spirito Santo invade le profondità dell’uomo e opera nel cuore del confermato. Il profumo, emanante verso l’esterno e percepito da altri, indica a sua volta l’efficacia dello Spirito Santo diretta verso l’esterno e verso il prossimo. Chi lo ha ricevuto e ha ricevuto i suoi doni, partecipa alla missione del Signore. Paolo lo esprime molto bene nella seconda lettera ai Corinzi: «Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare in ogni tempo al sud trionfo in Cristo, e diffonde per mezzo di noi il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti per Dio il profumo di Cristo tra quelli che si salvano e per quelli che vanno in rovina; per gli uni odore di morte, per la morte, e per gli altri odore di vita, per la vita» (2Cor 2,14-16). E infine un’ultima caratteristica dell’unzione. Il vescovo traccia col crisma il segno della croce sulla fronte del confermato. Egli sceglie il punto del corpo più esposto in pubblico, il punto che meglio incarna lo spirito di una persona. Chi su mandato di Cristo e impegnandosi per il suo regno sa «far fronte» a tutte le evenienze, testimonia «lo spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà». Con la confermazione comincia quel ch’era stato posto nel battesimo: la pubblica professione di fede in Cristo e l’impegno per gli uomini! I confermati adempiono quel che già fecero gli apostoli il giorno di Pentecoste: testimoniano davanti al mondo la morte e la Risurrezione del Signore. Mostrano davanti agli uomini che cosa significa vivere da cristiani. L’unzione della fronte col crisma è quindi un segno complesso, che indica tre cose: l’azione del Dio trino, la santificazione interiore del confermato e il compito che il cristiano maturo ha di annunciare.
Il termine “sacramentum” è stato mutuato dal linguaggio militare e indicava il giuramento di fedeltà che il soldato prestava all’imperatore, una sorta di consacrazione al suo signore e di cui portava sul corpo un “signum“.
Per analogia, Tertulliano, agli inizi del III sec., introduce nella chiesa e nella teologia il termine di “sacramentum militare” con cui definisce il battesimo, che ascrive il credente alla milizia sacra di Cristo. Fu così che il battesimo, conosciuto come mystherion di iniziazione, cominciò ad essere chiamato con l’espressione “sacramentum“. A partire, dunque, dal II sec. mystherion e sacramento tendono a fondersi, completandosi a vicenda.
“Sacramenta” non sono detti soltanto il battesimo e l’eucaristia, ma anche i piani di Dio che si attuano nella storia; “sacramentum” è pure detta anche la religione cristiana, che porta nascoste in sé le realtà divine. Rientrano nel termine “sacramentum” anche quelli propri di Israele, quali la circoncisione, sacrifici, la festa della Pasqua, l’unzione regale e sacerdotale, ecc.
Ma il sacramento maggiore, da cui defluisce l’intera sacramentalità, è l’incarnazione stessa di Cristo.
Il mystherion, primariamente, era un rito che aveva lo scopo di rendere presente un avvenimento di salvezza, avvenuto in tempi lontani, e solo secondariamente implicava una consacrazione alla divinità. Il termine deriva dal verbo greco muein, che significa chiudersi, rimanere chiuso. Esso indica, pertanto, una realtà che supera le capacità espressive del linguaggio umano, per cui “rimane chiusa, nascosta“.
Il concetto di “sacramentum” richiama, invece, primariamente l’idea di consacrazione. Infatti, il termine sacramento ha la sua origine etimologica in “sacrare“, che significa rendere sacro e, quindi, riservare alla divinità. A sua volta, “sacrare” deriva da “secare” che significa tagliare, separare. La consacrazione, quindi, è un atto che tende a separare le cose, sottraendole alla disponibilità umana per riservarle, invece, alla divinità.
LA CONFERMAZIONE
Premessa
La confermazione è un sacramento nato assieme al battesimo, ad esso strettamente legata e che nel suo contesto è sempre stata letta e compresa. Essa, più che una confermazione, era vista come una “cresima” (dal gr. criw = ungo), cioè un’unzione, attraverso cui il credente era consacrato a Dio nello Spirito.
Ma nel tempo, con il diffondersi del battesimo dei bambini e per altre ragioni storiche, si andò gradualmente staccandosi e la separazione divenne definitiva con la riforma carolingia. Così separata la confermazione perse la sua identità e venne compresa semplicemente come un sacramento complementare del battesimo. Ed ecco il primo interrogativo: perché complementare? Forse che il battesimo in sé è un sacramento imperfetto che abbisogna di un successivo sacramento per essere perfezionato?
Si vede, inoltre, la confermazione come il sacramento del dono dello Spirito. Sorge allora un secondo interrogativo: ma lo Spirito non è già dato nel battesimo? Quale Spirito dona, dunque, la confermazione che già non sia stato dato nel battesimo?
Interrogativi che denunciano come il dibattito sulla confermazione sia ancora aperto e sulla cui definizione c’è ancora molta incertezza. Così slegata dal battesimo essa ha perso la propria configurazione e rispetto al battesimo appare come la parente povera.
Per ritrovare il senso della confermazione bisogna ricollocarla all’interno dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, dove è nata: battesimo, cresima, eucaristia. Essi nella chiesa primitiva costituivano per il credente un unico atto, preceduto da un adeguato periodo, in genere triennale, di cammino catecumenale, che lo inseriva gradualmente nella comunità escatologica con cui condivideva la fede e la speranza.
Letti in questa prospettiva i tre sacramenti, somministrati nello stesso momento, costituivano da un lato, il vertice del cammino catecumenale; dall’altro, un’unica azione consacratoria. Sarà proprio la loro dilazione nel tempo che farà perdere il senso e la visione unitaria dei tre sacramenti, e ciò favorito anche dalla perdita di senso dell’iniziazione cristiana. Infatti, con l’ormai diffuso e consolidato cristianesimo, venne di fatto perduto il catecumenato e con questo anche il senso dell’iniziazione cristiana, di cui il catecumenato era parte importante e fondamentale.
Di conseguenza, i tre sacramenti, che costituivano il punto di arrivo dell’iniziazione e il consolidamento del credente all’interno della comunità, perdono il senso della loro unitarietà a favore di una nuova pastoralità, inaugurata con il battesimo dei bambini. Diventa gioco forza dilazionare e scandire nel tempo i tre sacramenti, che accompagnano in tal modo il bambino nella sua crescita, fino ad introdurlo responsabilmente nella comunità, in cui era già stato inconsciamente inserito in virtù del battesimo.
Questa dilazione, però, se pastoralmente aveva senso, ha provocato la perdita di un altro senso: quello dell’unità dei tre sacramenti, che ora, svincolati l’uno dall’altro, sono letti separatamente, perdendo parte del loro significato e, causando, in tal modo anche la perdita dell’identità della confermazione stessa.
L’iniziazione cristiana
E’ necessario, quindi, recuperare il significato dell’iniziazione cristiana al cui interno rileggere e ricomprendere i tre sacramenti, con particolare attenzione, nel nostro caso, alla confermazione.
L’inscindibile unitarietà dei tre sacramenti trova la sua giustificazione all’interno dello stesso mistero cristiano: uno è il Cristo morto e risorto che si dona nella parola, nel pane e nello Spirito.
In questo mistero è inserito il credente attraverso il triplice sacramento del battesimo, confermazione ed eucaristia, che con carisma proprio, incorporano il credente alla Chiesa e, per suo mezzo, in Cristo, unendolo alla sua morte e risurrezione, facendolo partecipe della natura stessa di Cristo, Figlio di Dio, e del suo triplice ufficio sacerdotale, regale e profetico. Mentre, grazie allo Spirito, il credente è rigenerato alla vita stessa di Dio e abilitato ad esercitare la sua connaturata missione di sacerdote, re e profeta. Chiamato alla testimonianza e all’esistenzializzazione personale della morte e risurrezione di Cristo, a cui è intimamente unito e conformato.
In questa prospettiva, l’iniziazione cristiana diventa un cammino fortemente accentrante e unificante al punto tale che potremmo quasi dire che i tre sacramenti sono in realtà un unico sacramento, che si scandisce in tre modi e forme diverse, perché uno è il Cristo che viene donato e a cui si viene incorporati. Cristo, infatti, è l’unico sacramento da cui ogni altra sacramentalità si origina e trae la propria giustificazione. Così che ogni sacramento, a sua volta, potremmo definirlo come una specificazione e attuazione dell’unica azione salvifica di Cristo.
Ricompresi, dunque, nell’ambito del mistero pasquale, i tre sacramenti configurano il credente al Cristo morto e risorto, lo associano alla sua missione salvifica, abilitandolo a compierla. Ciò significa che il cristiano, costituito come altro Cristo, diventa, grazie ai tre sacramenti, generatore, egli stesso, di salvezza e cooperatore di Cristo nella realizzazione del progetto salvifico di Dio, non certo per virtù propria, ma per quella di Cristo, che vive ed opera in lui (Gal 2,20).
LA CONFERMAZIONE: LE BASI BIBLICHE
Se leggiamo attentamente il NT, non troviamo in esso, come prassi normale, il conferimento dello Spirito, dato separatamente dal battesimo. In altri termini, non vi è un rito a se stante finalizzato al dono dello Spirito.
Per il NT il dono dello Spirito fa parte del battesimo. Giovanni, nel dialogo con Nicodemo, parla della nascita dall’acqua e dallo Spirito (Gv 3,5); mentre per Paolo il battesimo significa sempre anche dono dello Spirito.
Acqua e Spirito formano all’interno della Bibbia un connubio inscindibile, testimoniatoci anche dall’AT.
Infatti, l’A.T. è percorso dal simbolismo dell’acqua che purifica interiormente l’uomo e lo rigenera spiritualmente a Dio e che esprime l’azione dello Spirito di Dio sull’uomo. In Is 44,3 l’azione dell’acqua viene paragonata a quella dello Spirito: “… io farò scorre l’acqua sul suolo assetato … spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi posteri“; e ancora in Ez. 36,25-27: “Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati … vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo“. Ma, per venire in tempi più vicini a quelli del NT, anche nella regola del Qumran (1QS IV, 19-21) si leggeva l’azione dell’acqua come l’azione rigenerativa dello Spirito di Dio sull’uomo: “Io lo purificherò da tutte le sue azioni malvagie per mezzo di uno Spirito Santo; quasi acque purificatrici io aspergerò su di lui lo spirito di verità“.
A tal punto “acqua e Spirito” potrebbero essere lette come una sorta di endiadi: “l’acqua che è Spirito“.
Del resto nello stesso racconto del battesimo di Gesù, lo Spirito è associato e conseguente al battesimo: “Gesù … uscendo dall’acqua , vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba” (Mc 1,10).
Acqua e Spirito vengono associati per contrapposizione e per evoluzione in Mc 1,8: “Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito santo“. L’acqua veterotestamentaria di Giovanni si trasforma nel NT in Spirito, evidenziando ancor più la stretta connessione e la profetica evoluzione dell’acqua e dello Spirito.
E’ indubbio, quindi, che acqua e Spirito si configurino nella Bibbia come una sorta di sinonimo, così che l’acqua diventa ad essere l’esplicitazione dell’azione dello Spirito e in cui lo Spirito è, in qualche modo, raffigurato e significato.
Soltanto in due passi del NT il dono dello Spirito viene donato non per mezzo dell’acqua, bensì attraverso l’imposizione delle mani: “(lo Spirito Santo) infatti non era ancora sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano lor le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo” (At 8,16-17); e ancora: “Dopo aver udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo” (At 19,5-6).
Nella lettera agli Ebrei, databile intorno al 70, si fa una breve elencazione dei sacramenti in cui si associa il battesimo e l’imposizione delle mani come due momenti distinti e che si susseguono l’uno all’altro come un fatto ormai dottrinalmente acquisito e consolidato: “… passiamo a ciò che è più completo, …, della dottrina dei battesimi, della imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno” (Eb 6,1-2)
Infine, in At 10,44 e ss, vediamo come lo Spirito scende sui credenti ancora prima del battesimo: “Pietro stava dicendo ancora queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che stavano ascoltando il discorso. … Allora Pietro disse: <<Forse che si può proibire che siano battezzati con l’acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?>>” (At 10,44.47).
Dall’insieme dei passi fin qui citati, sembra che lo Spirito sia effuso non soltanto attraverso l’acqua, ma anche per mezzo dell’imposizione delle mani o per mezzo del semplice ascolto della Parola. Tutto ciò potrebbe far pensare, da un lato, che all’interno della chiesa nascente la prassi non fosse ancora consolidata; dall’altro, l’effusione dello Spirito in modi diversi (acqua, imposizione delle mani, ascolto della Parola) potrebbe significare una diversa azione dello Spirito sui credenti: nel caso del battesimo, ad esempio, potrebbe significare la rigenerazione alla vita stessa di Dio in cui l’uomo viene ricollocato; nel caso dell’imposizione delle mani, l’effusione dello Spirito poteva indicare una particolare investitura o missione all’interno della comunità; mentre nel caso dell’effusione per mezzo dell’ascolto della Parola, potrebbe indicare una specifica azione dello Spirito indicata nella Parola stessa, per cui la Parola, concepita come Dabar, cioè come azione di Dio, è “viva ed efficace” (Eb 4,12), cioè produce quello che dice. Sono chiaramente delle ipotesi, ma che, a mio avviso, non vanno aprioristicamente escluse.
Imposizione delle mani, unzione e sigillo
L’imposizione delle mani nella Bibbia assume significati diversi a seconda del contesto in cui si attua. Essa può significare un semplice gesto di affetto, ma anche di trasmissione di vita, forza, potere, energia, come azione benedicente o come affidamento di un incarico. Nel NT lo incontriamo più volte nell’attività taumaturgica di Gesù, quasi a significare l’infondere un’energia salvifica e rigenerante, per cui all’uomo viene restituita la sua originale dignità.
Quanto all’unzione, essa ha una radice molto antica e profana. Con l’olio, infatti, si ungevano i corpi dei lottatori per renderli viscidi alla presa, ma anche per renderli più elastici. Ci si ungeva, inoltre, il corpo dopo il bagno per ammorbidire la pelle, tonificarla e profumarla.
Questo aspetto profano viene recuperato anche nell’ambito di azioni sacre, in cui il significato è del tutto spirituale. In Israele, ma non solo, si ungevano i sacerdoti e i re, per cui l’espressione “l’unto di Dio” indicava l’unzione regale e una particolare consacrazione. Vediamo, poi, come il termine “Mashia” (unto), tradotto poi in greco con “cristoV“, acquisisce un significato del tutto particolare che indicherà “Salvatore escatologico“, colui che doveva realizzare in mezzo ad Israele le promesse di Dio. Indicava, dunque, l’uomo di Dio, l’inviato del Signore su cui riposava lo Spirito di Dio. E benché nel NT non si trovi nessuna “unzione“, tuttavia essa assume il significato metaforico di “conferimento dello Spirito“. Gesù, benché non unto fisicamente, assumerà il titolo di Cristo, per indicare l’unzione, cioè il ricevimento dello Spirito.
Quanto al sigillo, vediamo come questo nel NT sia assimilato al dono dello Spirito: “E’ Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori” (2Cor 1,21-22).
L’immagine del sigillo viene mutuata, anche questa, dall’uso corrente del sigillo che si faceva nell’antichità. Il sigillo era un segno che veniva impresso su contratti, documenti, sugli schiavi, sugli animali e richiamava l’appartenenza delle cose o delle persone o animali che portavano il sigillo. Esso esprimeva, dunque, un marchio di proprietà.
Concludendo, possiamo rilevare come l’imposizione delle mani e l’unzione nel mondo biblico diventano segni di consacrazione e di infusione di potere, energia e investitura, che verranno accolti anche nella realtà neotestamentaria, in cui significheranno l’iniziazione del credente; mentre il sigillo diventa un termine per indicare la conseguenza dell’imposizione delle mani e dell’unzione: la consacrazione, cioè l’appartenenza a Dio, del credente. Lo Spirito funge, dunque, da sigillo con cui il credente è segnato e dice la sua appartenenza a Dio e al suo mondo.
Sviluppo storico-dogmatico
Nella Chiesa antica non si conoscono riti di iniziazione di battesimo e confermazione tra loro separati, ma soltanto il battesimo, che avviene nell’acqua e nello Spirito (Mc 1,8; Gv 3,5; Tt 3,5; 1Cor 12,13). Esso comporta oltre che la remissione dei peccati, il dono dello Spirito. Lo stesso evento di Pentecoste è qualificato come battesimo e non come confermazione: “Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni” (At 1,5).
L’iniziazione cristiana nella Chiesa antica, dunque, è percepita come un fatto unitario, senza distinzioni. La teologia crismale si fonda ed è ricompresa in quella battesimale.
Un fatto, pertanto, appare chiaro: il dono dello Spirito, proprio del tempo messianico è tale che caratterizza la nuova comunità, è comunicato ad ogni battezzato, benché il modo del conferimento, come abbiamo visto in precedenza, non sia uniforme (acqua, imposizione delle mani e ascolto della Parola).
A partire dal IV sec. l’imposizione episcopale delle mani, comincia a separarsi dal battesimo. Il fattore determinante di questa separazione è il battesimo dei bambini. Ad essi non si può imporre un cammino catecumenale, non si può pretendere una scelta di vita e di fede. Per loro conto agiscono i genitori, che si assumono anche l’impegno di crescerli nella fede, in cui sono stati battezzati e grazie alla quale hanno ricevuto lo Spirito. Il “cammino catecumenale“, quindi, avviene dopo il battesimo e si inserisce nell’ambito dell’azione educativa e di catechesi del bambino. In altri termini, la fede cresce con il bambino che viene portato a compiere naturalmente e di fatto la scelta di vita cristiana, in cui è stato allevato.
Si rese, quindi, necessaria la dilazione del rito di iniziazione, che viene, così, spalmato lungo l’arco di vita e di crescita del bambino, segnandone i passaggi fondamentali. In tale orizzonte la confermazione assume anche il significato di una scelta personale e responsabile del proprio credere e del proprio impegno all’interno della comunità.
Ma nel tempo, tre sono stati gli elementi che hanno influito sulla separazione: a) lo sviluppo della dottrina del peccato originale, che ha spinto a battezzare i bambini; b) la riammissione nella Chiesa degli eretici battezzati, ai quali il vescovo imponeva le mani; c) la diffusione delle comunità ecclesiali e la crescente distinzione tra le funzioni del presbitero e quelle del vescovo, per cui i presbiteri battezzano, mentre soltanto al vescovo compete l’imposizione delle mani, la quale assume il significato di “confirmatio“, cioè di conferma, di ratifica e di completamento del battesimo.
Questa separazione tra battesimo e cresima o “confirmatio” che si opera in Occidente, non trova successo in Oriente che, invece, continua a mantenere integra l’unità dei tre sacramenti dell’iniziazione cristiana. Ancora oggi si amministra al neonato il battesimo, l’unzione con il muron e l’eucaristia assieme in un unico rito.
Ma una volta separata dal suo contesto naturale dell’iniziazione cristiana, la “confirmatio” perde la sua identità e diventa incomprensibile o, quanto meno, di difficile individuazione e collocazione. Si cerca, pertanto di attribuire a questo sacramento dei significati propri, ma sempre insoddisfacenti. Si parla, pertanto, di “pienezza del proprio essere cristiani“, “conferimento della missione dell’annunciare e testimoniare“, “rinvigorimento nella lotta contro il male“. Quest’ultimo aspetto diventa il motivo dominante nel periodo della Scolastica: il battesimo viene dato per la remissione dei peccati, mentre la cresima per il rinvigorimento spirituale del credente, che ora è chiamato alla lotta contro il male.
La Riforma protestante vede nella confermazione una svalutazione del battesimo e, in quanto sacramento non istituito da Gesù Cristo, perde la sua natura di sacramento.
Con l’avvento del Vaticano II (1962-1965), benché non venga elaborata una specifica teologia e dottrina sulla confermazione, né venga attua alcuna riforma del sacramento in questione, pur predisponendola, tuttavia, viene enunciato un principio di capitale importanza: “… più intimamente appaia l’intima connessione di questo sacramento con tutta l’iniziazione cristiana” (SC § 71). Finalmente la confermazione ha ritrovato la propria abitazione originale.
Concretamente la connessione con il battesimo viene attuata per mezzo del rinnovo delle promesse battesimali, posto all’inizio del rito, e con l’eucaristia, all’interno della quale viene celebrato il rito.
Quanto al tempo della confermazione, l’età è fissata verso i sette anni, ma è lasciata alla discrezionalità delle Conferenze episcopali il fissare anche un’età più matura, se lo ritengono pastoralmente più idoneo.
Ministro ordinario della confermazione è il vescovo, il quale, in caso di sua impossibilità, può anche delegare un semplice presbitero.
Il riconoscere il vescovo come ministro ordinario della confermazione assume all’interno della Chiesa una notevole importanza. Infatti, vi è chiesa universale là dove c’è il vescovo. Egli è il pastore per eccellenza che dà garanzia alla fede e attorno a lui si costituisce la comunità. La confermazione, quindi, amministrata dal vescovo, assume una valenza tutta ecclesiale e dice l’introduzione e l’accoglienza ufficiali del credente all’interno della comunità, sancendone i diritti e i doveri. E’ il vescovo, quindi, che con la confermazione introduce ufficialmente il battezzato nella comunità, lo rende responsabile di fronte ad essa e ne sollecita l’impegno e la testimonianza.
Circa il rito essenziale della confermazione, Paolo VI nel 1971 ha stabilito che “il sacramento della confermazione si conferisce mediante l’unzione del crisma sulla fronte, che si fa l’imposizione della mano e mediante le parole: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono“. Con tale nuova formulazione si è ripresa un’antica formula del IV sec., che vede la confermazione come il sigillo dello Spirito impresso sul credente.
«Credete nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, è in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste?». Questa domanda del vescovo fa parte della professione battesimale di fede, che i bambini, i giovani e gli adulti emettono immediatamente prima della confermazione. Essi ripetono quanto i padrini al loro posto o essi stessi hanno professato con fede il giorno del battesimo: lo Spirito Santo è Dio col Padre e col Figlio e dà la vita. Nella confermazione egli sigillerà semplicemente quanto ha già operato nel battesimo. «Ricevi il sigillo – e così dicendo il vescovo traccia col crisma un segno di croce sulla fronte del confermando – dello Spirito Santo che ti è dato in dono».
I Padri della Chiesa spiegarono bene il significato dell’unzione col crisma. Essi si servirono di un paragone: l’ulivo col suo tronco, i suoi rami e le sue foglie è l’immagine di Dio Padre. Il frutto dell’ulivo è l’immagine di Gesù Cristo; l’olio ricavato dalla spremitura del frutto – per così dire la parte costitutiva più raffinata dell’ulivo – è un’immagine dello Spirito Santo. Ciò significa: come l’olio e il frutto e il tronco di un albero sono un tutt’uno, così Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo! Come l’olio deriva dai fiori e dai frutti, e come i frutti derivano dal tronco e dai rami, così lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio.
«Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, affinché sia sempre con voi… Quando verrà il Paraclito – leggiamo un poco più avanti nel vangelo di Giovanni – che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi darà testimonianza» (Gv 14,16; 15,26). L’olio dell’unzione, nel linguaggio dei Padri della Chiesa e anche nel linguaggio dei nostri giorni, è un segno dello Spirito Santo e contemporaneamente un simbolo dell’efficacia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Ma l’olio dell’unzione usato nella confermazione contiene ancora un’aggiunta preziosa: il balsamo. Tale olio, detto crisma nel linguaggio tecnico, emana un profumo gradevole. Pure questo particolare è importante per il simbolismo. Il crisma penetrante a fondo nei pori indica che lo Spirito Santo invade le profondità dell’uomo e opera nel cuore del confermato. Il profumo, emanante verso l’esterno e percepito da altri, indica a sua volta l’efficacia dello Spirito Santo diretta verso l’esterno e verso il prossimo. Chi lo ha ricevuto e ha ricevuto i suoi doni, partecipa alla missione del Signore. Paolo lo esprime molto bene nella seconda lettera ai Corinzi: «Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare in ogni tempo al sud trionfo in Cristo, e diffonde per mezzo di noi il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti per Dio il profumo di Cristo tra quelli che si salvano e per quelli che vanno in rovina; per gli uni odore di morte, per la morte, e per gli altri odore di vita, per la vita» (2Cor 2,14-16).
E infine un’ultima caratteristica dell’unzione. Il vescovo traccia col crisma il segno della croce sulla fronte del confermato. Egli sceglie il punto del corpo più esposto in pubblico, il punto che meglio incarna lo spirito di una persona. Chi su mandato di Cristo e impegnandosi per il suo regno sa «far fronte» a tutte le evenienze, testimonia «lo spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà». Con la confermazione comincia quel ch’era stato posto nel battesimo: la pubblica professione di fede in Cristo e l’impegno per gli uomini! I confermati adempiono quel che già fecero gli apostoli il giorno di Pentecoste: testimoniano davanti al mondo la morte e la Risurrezione del Signore. Mostrano davanti agli uomini che cosa significa vivere da cristiani.
L’unzione della fronte col crisma è quindi un segno complesso, che indica tre cose: l’azione del Dio trino, la santificazione interiore del confermato e il compito che il cristiano maturo ha di annunciare.
LA MISTAGOGIA DEL 3° GIORNO: LA CRISMAZIONE
Ieri abbiamo disputato del fonte, la cui apparenza è come la forma del sepolcro. Pertanto anche nel battesimo, poiché vi è la similitudine della morte, vi è indubbiamente, mentre ti immergi e risorgi, anche la similitudine della risurrezione. Segue il sigillo spirituale, poiché, dopo il fonte, RIMANE DA PORTARE A COMGPIMENTO [QUANTO GIÀ È AVVENUTO] (SUPEREST UT PERFECTIO FIAT), quando all’invocazione del sacerdote lo Spirito Santo viene infuso, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di pietà, Spirito del santo timore, che sono le sette virtù dello Spirito… 3,15 Sei andato, ti sei lavato, sei venuto all’altare (isti, lavisti, venisti ad altare), hai cominciato a vedere ciò che prima non vedevi; e cioè: attraverso il fonte del Signore e la proclamazione della passione del Signore, in quell’istante si sono aperti i tuoi occhi. Tu che prima figuravi con il cuore accecato, hai cominciato a vedere la luce dei sacramenti. Siamo dunque venuti, fratelli carissimi, fino all’altare, a un trattato più ricco. Per questo motivo, e poiché è tardi, non possiamo iniziare la spiegazione completa, dal momento che il trattato è più lungo. Basti ciò che è stato detto oggi. medesimo istante voi siete morti e siete nati: QUELL’ACQUA SALVIFICA È DI- VENUTA PER VOI TOMBA E MADRE (tavfo” uJmi’n ejgivneto kai; mhvthr)!… 2,5 O fatto strano e paradossale! [Noi] non siamo veramente [= fisicamente] morti, non siamo stati veramente sepolti, né dopo essere stati crocifissi siamo veramente risorti; ma [se] l’imitazione [avviene] in figura, la salvezza [è conseguita] in verità [= nella realtà piena, totale] (ajll!ejn eijkovni hJ mivmhsi”, ejn ajlhqeiva/ de; hJ swthriva). Cri- sto fu veramente [= fisicamente] crocifisso e fu veramente sepolto e veramente ri- sorse; e tutte queste cose [egli] ha graziosamente elargito a noi, affinché, comuni- cando (koinwnei’n) alla figura [sacramentale] (mivmhsi”) delle sue sofferenze, potes- simo guadagnare in verità la salvezza. O smisurata filantropia! Cristo ricevette sulle sue mani pure i chiodi e soffrì; e a me, senza sofferenza e senza pena, elargisce gra- ziosamente, attraverso la koinonia [sacramentale] (dia; th'” koinwniva”), la salvezza [cf testo & commento in “Eucaristia per la Chiesa”, p. 614]. 2,6 Pertanto, nessuno pensi che il battesimo ottiene soltanto la grazia della remissione dei peccati e dell’adozione a figli, come il battesimo di Giovanni che procurava solo la remissione dei peccati. Ma, siccome noi veniamo istruiti con acribia (ajkribw'”), [sappiamo] che esso, come è purificazione dei peccati e dono dello Spirito santo, così è anche figura [sacramentale] (ajntivtupon) della passione di Cristo. Proprio per questo Paolo diceva esclamando poco fa: «O forse ignorate che noi tutti che siamo stati battezzati [= immersi = sepolti] in riferimento a Cristo Gesù, è in riferimento alla sua morte che siamo stati battezzati [= immersi = sepolti]? Siamo stati dunque sepolti con lui per mezzo del battesimo [= immersione]» [Rom 6,3-4]… 2,7 Dobbiamo dunque impararlo: tutto quello che Cristo ha sofferto, l’ha sostenuto per noi e per la nostra salvezza in verità (ejn ajlhqeija/), e non in apparenza (kai; oujk ejn dokhvsei); e noi diveniamo partecipi (koinwnoiv) delle sue sofferenze. [Perciò] con ogni acribia (ajkribeiva) Paolo esclama: «Infatti, se siamo stati intimamente congiunti alla figura (oJmoivwma) della sua morte, ma anche [alla figura] della sua risurrezione saremo [intimamente congiunti]!» [Rom 6,5]… Veramente infatti a Cristo [toccò] una morte reale [= fisica], la sua anima fu separata dal corpo e fu vera la sepoltura, poiché in una sindone pura fu avvolto il suo santo corpo, e tutto per lui avvenne in verità. Per noi invece [è posta in atto] la figura della morte e delle sofferenze; ma quando si tratta di salvezza, [quella] non è più figura, bensì verità (oujc oJmoivwma, ajlla; ajlhv- qeia). 2,8 Istruiti a sufficienza su queste cose, procurate di tenerle a mente, ve ne prego… LA MISTAGOGIA DEL 3° GIORNO: LA CRISMAZIONE 3,1 Battezzati in Cristo e rivestiti di Cristo, siete divenuti conformi (suvmmorfoi) al Figlio di Dio… Ora egli, lavatosi nel fiume Giordano e avendo comunicato alle acque il contatto corporale della sua divinità, ne uscì e si produsse su lui la venuta sostanzia- le dello Spirito santo, il simile riposando sul simile. Così [è avvenuto] anche per voi: appena usciti dalla piscina delle sante acque, vi è stato dato il crisma, figura CESARE GIRAUDO / BCE / Cap. 7: Complementi al trattato mistagogico De eucharistia / PUG TP1015 & Sezione San Luigi / 2009-10 77 Domani, se al Signore piacerà, tratteremo dei sacramenti stessi. LA MISTAGOGIA DEL